Dal progetto Life BEEadapt nuove strategie per favorire l’adattamento degli impollinatori selvatici ai cambiamenti climatici e contrastarne il declino.
di Gabriella Congedo
26 marzo 2025
 Un patto per tutelare gli impollinatori selvatici e favorire il loro adattamento ai cambiamenti climatici. È l’obiettivo del progetto LIFE BEEadapt in corso dal 2022 nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano. Cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Ente parco LIFE BEEadapt vede la partecipazione di altri nove partner distribuiti tra Toscana, Marche e Lazio e coinvolge attori chiave come le aziende agricole.
Un patto per tutelare gli impollinatori selvatici e favorire il loro adattamento ai cambiamenti climatici. È l’obiettivo del progetto LIFE BEEadapt in corso dal 2022 nel Parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano. Cofinanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’Ente parco LIFE BEEadapt vede la partecipazione di altri nove partner distribuiti tra Toscana, Marche e Lazio e coinvolge attori chiave come le aziende agricole.
Molte specie di impollinatori selvatici delle 1.100 conosciute sono minacciate di estinzione, in primis api e farfalle. Un declino che dura da alcuni decenni e diventa sempre più preoccupante. Dall’impollinazione infatti dipende gran parte della produzione agricola e l’equilibrio degli ecosistemi.
Le cause sono direttamente attribuibili all’uomo: “Inquinamento, consumo di suolo, introduzione di specie aliene, pesticidi, patogeni, apicoltura intensiva e trasporto su larga scala di colonie di api, che favoriscono la diffusione di parassiti e patogeni – ricorda Giovanni Carotti, entomologo del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano – Ad esempio, in Germania il primo crollo degli insetti si è registrato con l’introduzione del DDT: in 27 anni è stato osservato un calo del 75% degli insetti volatori”.
A tutto ciò si aggiunge il cambiamento climatico. L’aumento delle temperature e degli eventi estremi, soprattutto in primavera, rendono più difficile per gli impollinatori trovare condizioni favorevoli alla loro attività. Le piante fioriscono in anticipo o si spostano più in alto complicando ulteriormente il lavoro degli insetti.
Nidi e “Accordi di custodia” con gli agricoltori
Per venire in aiuto a questi straordinari operai dell’ecosistema LIFE BEEadapt sta sperimentando strategie di adattamento climatico per gli impollinatori selvatici. Sono coinvolte 64 aziende agricole su una superficie di quasi 70 ettari.
Cosa si sta facendo in concreto lo spiega Margherita Coviello, giovane entomologa che collabora con il Parco: “Stiamo posizionando sul territorio nidi per gli impollinatori. Si tratta di strutture di legno con fori di vario diametro, per ora ne abbiamo posizionati circa 160. Stiamo proponendo alle aziende agricole la stipula di “Patti” e “Accordi di custodia”. Possono riguardare la semina di specie botaniche appetibili per gli impollinatori, l’installazione di bee hotel, lo sfalcio ritardato. Tutte azioni per le quali sono previsti indennizzi adeguati al valore del servizio ecosistemico dell’impollinazione”.
Dodici transetti per individuare gli impollinatori
Un aspetto strategico del progetto riguarda il monitoraggio della presenza, distribuzione e ritmi di attività degli impollinatori nel Parco nazionale. La metodologia è quella proposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale). Sono stati individuati 12 “transetti” (lunghezza di 500 metri, con 2,5 metri per lato) sia in praterie d’alta quota che negli agro-ecosistemi dove si pratica la foraggicoltura. Questi transetti vengono percorsi una volta al mese, da giugno a settembre, consentendo agli entomologi del Parco di collezionare dati sulla presenza degli insetti. I dati emersi finora sono sconfortanti, la presenza degli impollinatori è limitata anche in aree naturali come quelle monitorate.
Sono dati che dovrebbero farci riflettere sulla direzione presa dal cosiddetto progresso. “Gli insetti impollinatori rappresentano una componente chiave per la riproduzione vegetale e per la biodiversità globale perché forniscono servizi ecosistemici vitali alle colture e alle piante selvatiche di fondamentale importanza per l’umanità – commenta Giovanni Carotti – Ecco perché il loro declino è così preoccupante”.

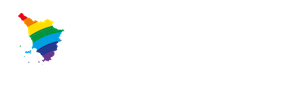
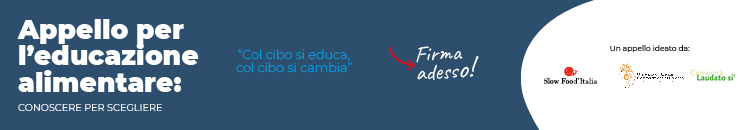






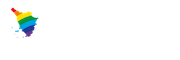



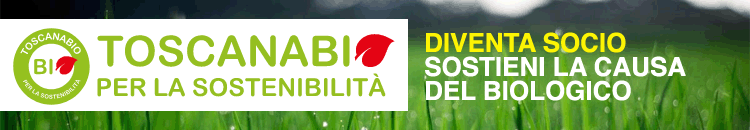






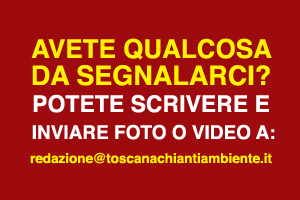








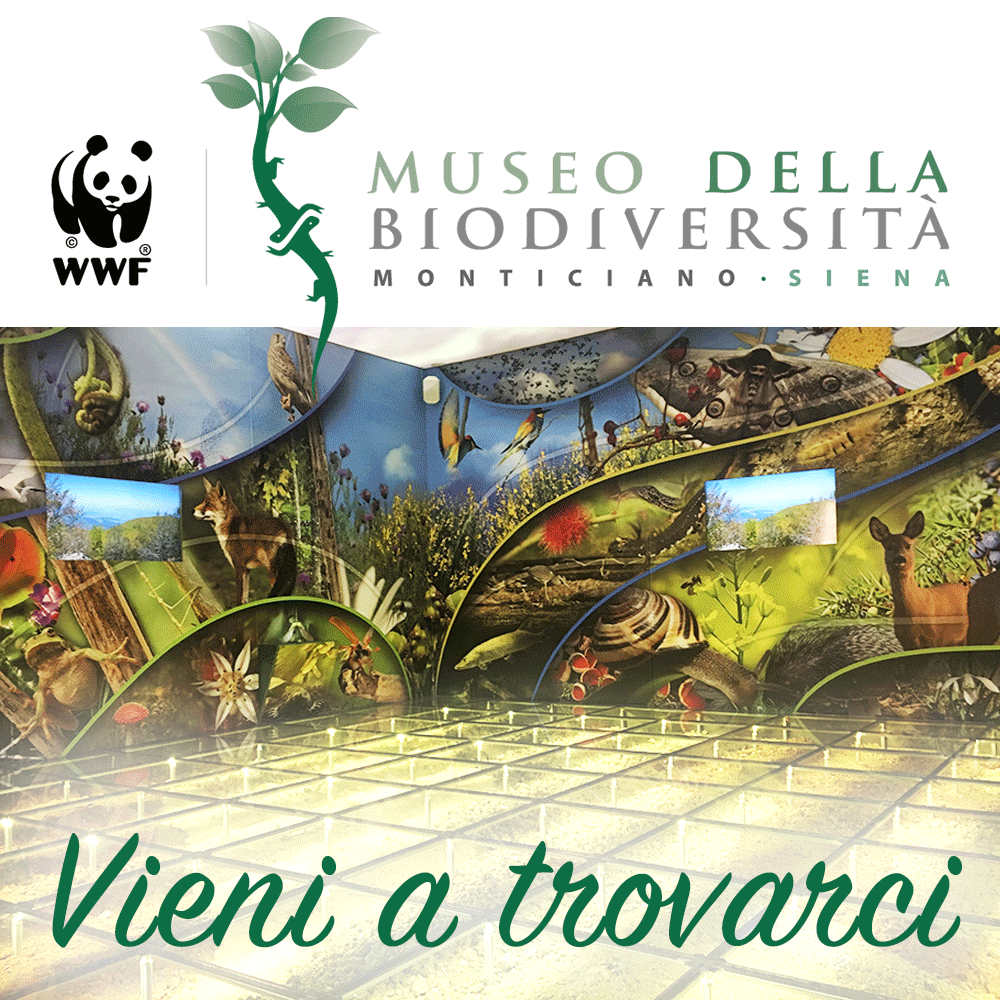







Aggiungi un commento