Una ricerca sugli scambi metabolici con le leguminose rivela il potenziale di questi batteri come fertilizzanti al posto di analoghi prodotti industriali a base di azoto.
FIRENZE – Si chiamano simbiosi le associazioni in natura fra più individui di specie diverse che consentono un reciproco vantaggio. E’ il caso dei rizobi, batteri del suolo, che entrando in relazione con le leguminose riescono a trasformare l’azoto atmosferico in ammonio, fondamentale per la sintesi delle proteine. Nasce così un delicato equilibrio in cui la pianta cede proprie risorse al batterio per permettergli di produrre ammonio, facendo attenzione però a non limitare eccessivamente la propria crescita proprio a causa di queste risorse cedute al suo “ospite”, che si installa nelle radici della pianta in regioni dette “noduli”.
L’enorme complessità di scambi metabolici fra piante e batteri è stata ora studiata e ricostruita attraverso un modello virtuale di nodulo (nominato ViNE per “Virtual Nodule Environment”) in uno studio pubblicato su Nature Communications, guidato dall’Università di Firenze in collaborazione con Queen’s University (Canada) e Luxemburg University. In campo applicativo i rizobi hanno riscosso grande interesse per la possibilità di utilizzarli come fertilizzanti al posto di analoghi prodotti industriali a base di azoto.
“Si tratta – spiegano Marco Fondi e Alessio Mengoni, rispettivamente ricercatore e docente di Genetica al Dipartimento di Biologia, autori della ricerca insieme al giovane ricercatore Michelangelo Tesi – di uno dei primi modelli che prende in considerazione il processo generale di simbiosi, uno dei più grandi e comprensivi, di circa 6500 reazioni metaboliche al suo interno. Finora ha permesso di capire qual è l’effetto, sulla crescita della pianta, di una fissazione dell’azoto più o meno efficiente e come il metabolismo del batterio cambi durante le diverse fasi della simbiosi. Ma in futuro, ViNE rappresenterà una risorsa per l’intera comunità scientifica impegnata sul fronte dei rapporti batteri-piante”.
Fonte: Università di Firenze












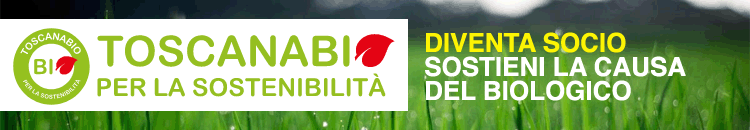















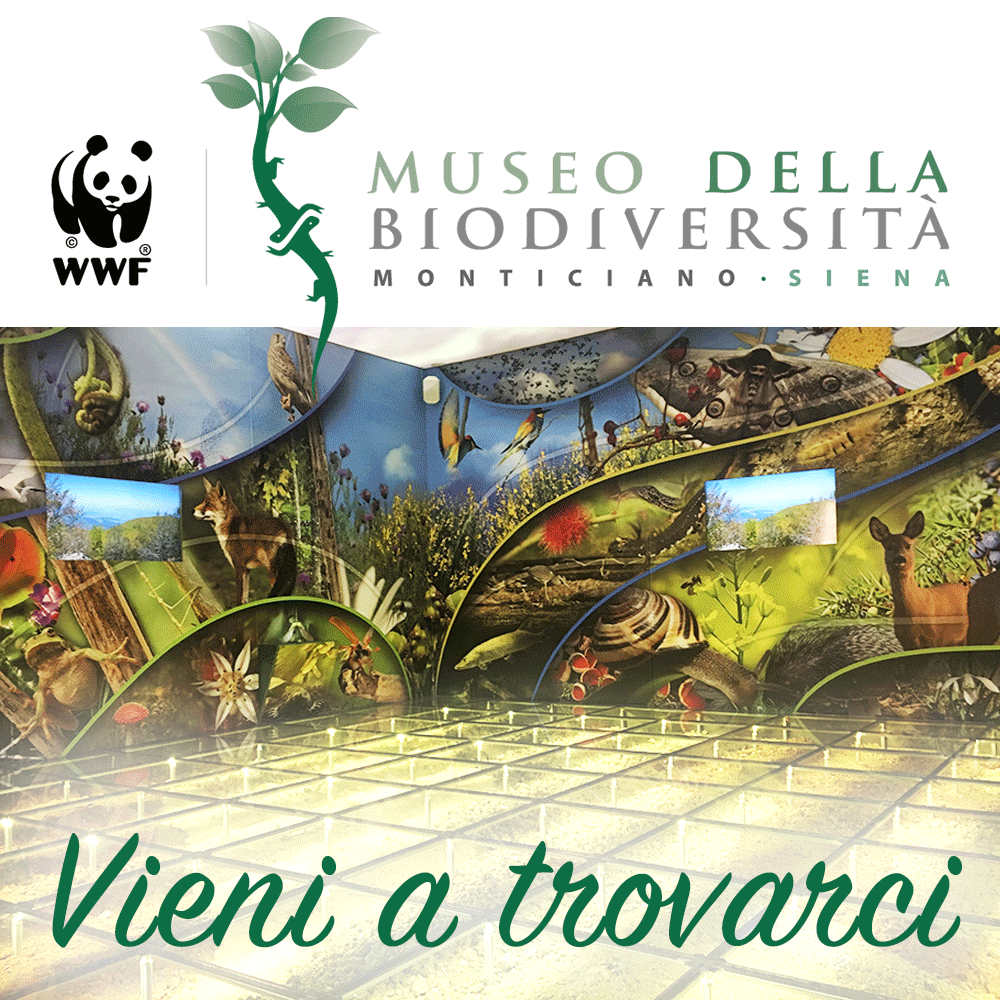







Aggiungi un commento