Perse dai pescherecci e non recuperate, sono praticamente indistruttibili e ricoprono come macabri festoni interi tratti di scogliera. Sarebbe necessario un progetto di recupero.
di “Popi” Giuseppe Adriani
Circolo della Vela di Marciana Marina
ISOLA D’ELBA (LI) – Tra i numerosi strumenti impiegati dall’uomo, oltre alle nasse e i palamiti, le reti, nelle loro diverse forme e tipologie, rappresentano il sistema principale di contenimento e cattura dei grandi branchi di pesce; sono molto redditizie e se usate con correttezza riducono il danno per l’ambiente marino circostante allo stretto necessario.
Da sempre nell’attività di pesca con le reti (che hanno nomi diversi, a seconda delle zone e dei tipi di impiego, tra cui i più noti sono i tramagli, le paranze o zaccarene) inconvenienti vari portano alla “ferratura” con conseguente perdita di spezzoni o di reti intere, che diventano quindi parte integrante degli scogli o dei relitti in profondità. Un tempo si tessevano i “tremagli” impiegando fibre vegetali, ed erano quindi biodegradabili, destinati a decomporsi nel giro di qualche anno. Oggi le reti sono realizzate con polimeri sintetici (come poliesteri, dacron) diventando praticamente indistruttibili.
Mi immergo da oltre trent’anni a profondità anche cospicue nelle acque dell’Arcipelago toscano, e ho potuto più volte constatare la presenza di queste reti avviluppate intorno agli scogli, che si trasformano in trappole mortali, non solo per la fauna marina, ma anche per eventuali subacquei poco esperti.
Questi “mestieri” dalla vita attiva infinita provocano un danno incalcolabile: continuano a pescare le prede di pezzatura più grossa, impediscono la pastura e la nidificazione alla fauna ittica di scoglio, soffocano il benthos (progenitore di tutte le forme di vita legate allo sviluppo del coralligeno, dalle gorgonie al corallo), trattengono fango sullo scoglio stesso provocando spesso anche la distruzione della flora. Esplorando i fondali dell’Arcipelago, a profondità dai 30 ai 60 metri ho potuto constatare come questo fenomeno sia in forte incremento, soprattutto se paragonato a quanto si poteva osservare alla fine degli anni ‘80. Questo aggravarsi della situazione è probabilmente imputabile a un insieme di fattori: minore professionalità di chi va per mare, diminuzione dei costi degli attrezzi da pesca, e quindi minore interesse a ingegnarsi per il recupero dei materiali persi, oltre alla ridondante, (la definirei esagerata) robustezza degli stessi che ne impedisce il degrado anche parziale.
In certi casi gli strati sovrapposti di tramaglioni si alternano a spezzoni del sacco della paranza, ricoprendo come macabri festoni interi tratti di scogliera. Altre volte l’insistenza con cui cavi e anelli si avvinghiano in maniera indissolubile al substrato fanno pensare a un errore di calcolo da parte di chi ha calato la rete, fraintendendo il segnale dello scandaglio. Ci si immagina di essere alla presenza di un fitto branco di pesce, anziché di un solido pinnacolo roccioso.
Questa grave condizione di degrado può essere in parte responsabile della diminuzione di pesce nelle acque dell’Arcipelago e sarebbe auspicabile approntare un progetto di recupero di queste reti perse per il benessere del nostro mare. Per evitare il proseguire di un simile silenzioso e inutile massacro di fauna marina pregiata, sarebbe opportuno prevedere il recupero di tali strumenti fatiscenti, con l’ausilio di imbarcazioni attrezzate. Occorrono operatori subacquei preparati alle immersioni ad alta profondità, coadiuvati da Rov o telecamere subacquee per ricerche sul fondo marino e verricelli adatti al recupero delle suddette reti.
Sarebbe opportuno, in contemporanea, magari in collaborazione con l’Ente Parco e la Guardia costiera, divulgare il materiale audiovisivo, realizzato durante le fasi di bonifica, per sensibilizzare i pescatori (i principali responsabili di tale indesiderato scempio, e quelli che ne subiscono per primi le conseguenze) a evitare il ripetersi di simili fenomeni.
Ho ripreso quanto già scritto a suo tempo per il Circolo della Vela di Marciana Marina (“Reti abbandonate” – Primavera del 2005) su suggerimento dell’amico Leonardo, e a seguito di un personale moto di risentimento dopo la recente immersione nelle acque del Careno. Parliamo di uno dei luoghi più interessanti da un punto di vista biologico e naturalistico dell’Isola d’Elba.
A poche centinaia di metri dal promontorio di Sant’Andrea, a una profondità che varia dai 10 ai 50 metri, si erge una sorta di bastione roccioso, al confine con una vasta prateria di Posidonia, che prosegue lungo tutta la costa per quasi un chilometro. Si tratta di un insieme di “secche” e scogli franati, alternati a ripide discese di sabbia, in cui da sempre albergano o transitano una miriade di specie ittiche pregiate. Questo è un vero paradiso dei pelagici di pezzatura importante; ricciole e dentici sono di casa. Ma può capitare di incontrare l’Aquila di mare, che si sposta a mezz’acqua con i barracuda sullo sfondo, fino alla immensa mobula (o manta mediterranea) che di recente si mostra con maggiore frequenza.
Oggi il panorama è davvero deprimente; l’intreccio dei vari sistemi di reti, sovrapposti fino anche a tre o quattro strati, rende quasi impossibile l’accesso alla fauna nelle numerose grotte che rendevano il Careno un luogo stupendo e unico per la nidificazione di pesci e crostacei.
Lo scenario si commenta da solo; la rete è divenuta una specie di festone incrostato da alghe e briozoi, che contribuiscono a rendere sempre più massicci i vari filamenti. I sedimenti, organici e non, tendono a depositarsi sulle maglie, appesantendo l’insieme in maniera massiva, fino a rendere il tutto simile a un arazzo impermeabile anche alla luce.
Tra le altre cose esisterebbe una norma specifica che – obbligando a identificare in maniera certa il tramaglio prima che venga posato – imputa una precisa responsabilità da parte di chi lo abbandona. La rimozione dovrebbe essere a carico di chi ne è direttamente responsabile.
Difatti a livello ministeriale è stato emesso uno specifico Codice di buone pratiche per limitare la perdita e l’abbandono delle attrezzature da pesca in mare. Dal quale è scaturito un bel progetto europeo: il Regolamento CE 1224/2009 Articolo 8 “Marcatura degli attrezzi da pesca”.
- Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.
- Le modalità di applicazione relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 119.
Articolo 48 “Recupero degli attrezzi perduti”.
- I pescherecci comunitari dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero degli attrezzi perduti.
- Il comandante di un peschereccio comunitario che ha perso gli attrezzi o una parte di essi cerca di recuperarli quanto prima possibile.
- Se gli attrezzi perduti non possono essere recuperati, il comandante della nave comunica all’autorità competente del suo Stato membro di bandiera, la quale informa a sua volta l’autorità competente dello Stato membro costiero, entro 24 ore, i seguenti dati: a) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio; b) tipo di attrezzi perduti; c) ora della perdita; d) luogo della perdita; e) misure messe in atto per recuperare gli attrezzi.
- Le autorità competenti degli Stati membri che recuperino un attrezzo del quale non è stata notificata la perdita possono chiedere il rimborso dei costi sostenuti al comandante del peschereccio che ha perduto l’attrezzo.
- Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri battenti la loro bandiera dalle prescrizioni di cui al paragrafo 2 se: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.




























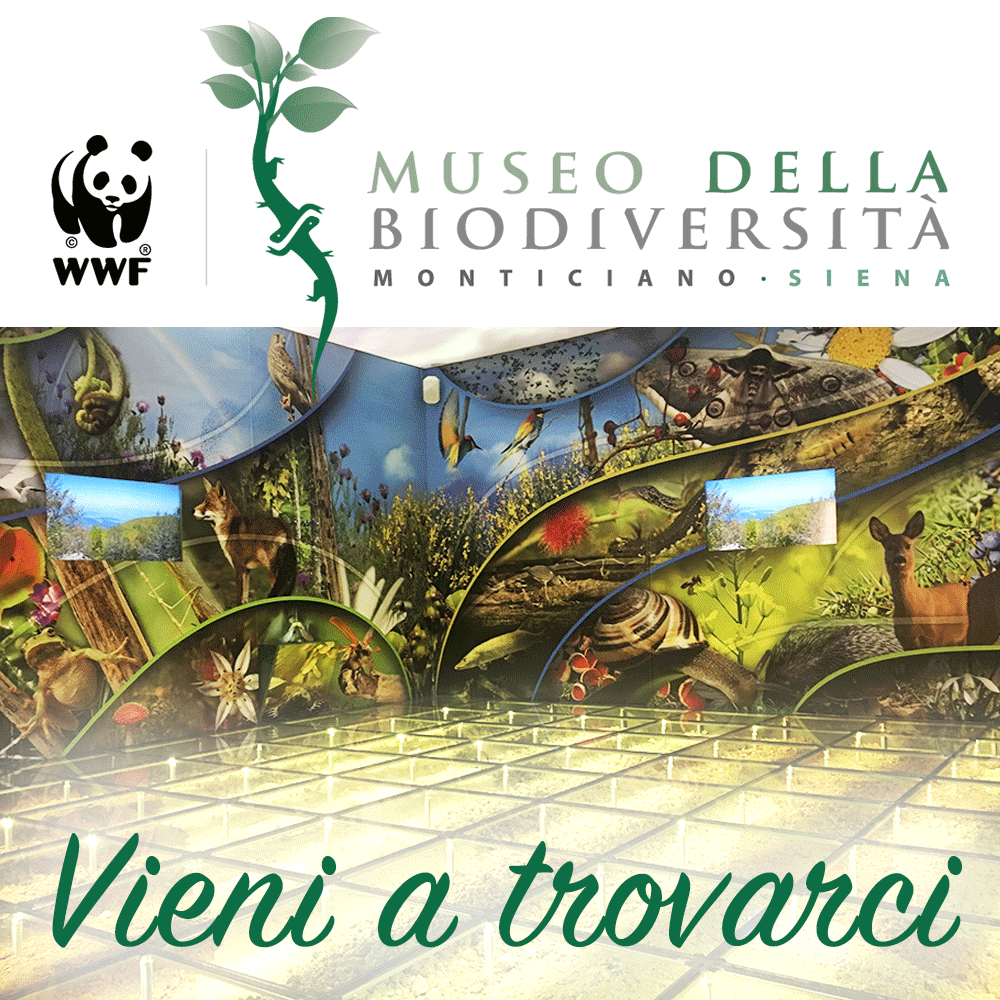






Aggiungi un commento